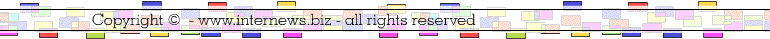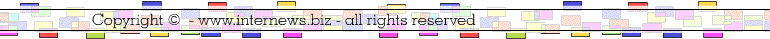|
11 ottobre 2007
«Organizzato dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con
Assoedilizia e il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Milano,
Comune di Milano, si è svolto a Milano il Convegno "Il federalismo
fiscale-Analisi e ipotesi di lavoro" Sono intervenuti, quali relatori,
Gianfranco Gaffuri, Ordinario di Diritto Tributario nell'Università
degli Studi di Milano - Achille Colombo Clerici, Presidente di
Assoedilizia - Giancarlo Pagliarini, Presidente della Commissione
federalismo fiscale del Comune di Milano - Nicolò Zanon, Ordinario di
Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Milano - Giancarlo
Penco, Consigliere della Sezione di Controllo della Corte dei
Conti-Lombardia - Pierangelo Spano, Ricercatore del Cergas
dell'Università Bocconi. I lavori, ai quali hanno portato il saluto
parlamentari e rappresentanti della pubblica amministrazione.
Secondo quanto risulta dalle ricerche compiute dal Centro Studi di
Assoedilizia e pubblicati nel corso di quest’anno in varie riprese sul
Sole 24 Ore, emergono alcune anomalie di fondo del sistema Italia
rispetto alla generalità degli altri Paesi europei;
1) Anzitutto il nostro Paese presenta un rapporto particolarmente
squilibrato tra il prelievo fiscale locale e quello erariale. Il 95%
dell’intero gettito fiscale è assorbito dallo Stato, mentre solo il 5%
(la metà di quanto si riscontra negli omologhi Paesi europei) è
prelevato direttamente dagli enti locali in virtù di una autonomia
impositiva ufficialmente riconosciuta. Il nostro è dunque un sistema di
finanza locale derivata, decisamente basato sul meccanismo dei
trasferimenti, degli investimenti diretti, dei finanziamenti erogati
dallo Stato centrale, e della compartecipazione alle imposte erariali.
2) Altra anomalia del sistema fiscale italiano rispetto a quelli del
resto dell’Europa è il rapporto invertito, tra il gettito delle imposte
dirette e quello delle imposte indirette. Ad esempio, il primo supera
l’altro del 20%; mentre in Francia è l’opposto: il secondo supera il
primo di circa il 30%; in Germania di quasi il 50%; in Spagna del 15%;
in Portogallo del 100%. Semplificando, le imposte dirette colpiscono non
la capacità di spendere, ma quella di guadagnare. Con la conseguenza
che, se i redditi non vengono dichiarati o lo sono in modo irregolare,
si dà luogo all’evasione fiscale che in Italia viene stimato nell’ordine
del 24% del PIL; contro il 16% della Germania, il 14% della Francia, il
12% della Gran Bretagna. Solo il Portogallo ci supera con il 30%. Con le
imposte indirette, viceversa, è più facile bypassare i fenomeni di
evasione o di elusione, in quanto incidono in sede di spesa, di
trasferimenti o di investimenti economici.
3) Altro dato interessante è quello del residuo fiscale pro capite
(equivalente a quanto, per abitante, rimane allo stato centrale del
prelievo erariale nelle singole aree regionali, dedotto quanto lo Stato
"spende" nelle regioni stesse): in Lombardia è di 3.292 euro per
abitante, in Emilia Romagna di 2.643, in Veneto di 2.513, in Piemonte di
316, in Toscana di 180. Nel resto del Paese il saldo è negativo. Lo
Stato quindi paga di più per ogni abitante di quanto percepisca di
tasse, per via della combinazione di due fattori: minor reddito e
maggiore evasione. I dati statistici dicono inoltre che il reddito delle
regioni settentrionali è mediamente superiore del 35-40% rispetto a
quello delle regioni meridionali.
E’ questa la prima difficoltà sul percorso del federalismo fiscale, in
quanto è chiaro che non si può consentire alle regioni più ricche di
"tenersi tutto": ciò causerebbe una sperequazione evidente, contraria ai
principi di solidarietà e di sussidiaretà, inammissibile in uno Stato
moderno e progredito.
Perequazione, dunque. Che significa però , non far diventare più ricche
le regioni più povere, ma equiparare sul piano della fruizione dei
servizi i cittadini delle seconde rispetto a quelli delle prime.
E' questa la luce più corretta nella quale cominciare a parlare di
federalismo fiscale, inquadrando il ruolo della sussidiarietà.
Sussidiarietà non solo verticale, dal pubblico al privato, dallo Stato
al cittadino (secondo la teoria del telescopio cara a Pietro Giarda) ma
orizzontale, tra enti ed istituzioni. Il principio di sussidiarietà e di
adeguatezza che, in materia amministrativa deve improntare i rapporti
tra i vari enti locali comporta che ad operare debba essere l’ente più
adatto, nel senso di più efficace, secondo il criterio della maggior
vicinanza al bisogno su cui intervenire. La sussidiarietà suppone a sua
volta una maggiore autonomia degli enti locali, nel differenziare le
politiche in relazione ai diversi bisogni locali, e la parallela
maggiore responsabilizzazione degli stessi nella gestione delle risorse
fiscali, (che implica una responsabilità, sia nella provvista delle
risorse finanziarie sia nella destinazione delle stesse ai diversi
bisogni).
Questo passaggio si ottiene attraverso un riequilibrio del rapporto tra
prelievo fiscale centrale e prelievo locale, al quale dovrebbe essere,
alla fine, affidato il compito di finanziare la spesa pubblica locale.
Il principio è quello secondo il quale per ogni euro pagato in più dai
contribuenti a Comuni, Province, Regioni, e a qualsiasi altro ente
locale (comunità montane, consorzi di bonifica e quant’altro), se ne
deve pagare uno in meno allo Stato.
Solo in questo modo si potrà pensare alla possibilità di quell’ampliamento
della autonomia impositiva degli enti locali, che è condizione
ineludibile perchè gli stessi possano assolvere pienamente al proprio
ruolo.
Ma l’attuale sistema della finanza locale non può neppure prestarsi,
così com’è, ad una operazione di questo genere. Si avrebbero infatti
degli effetti fortemente sperequati, perchè l’unica imposta in cui si
configurano la capacità e la autonomia dell’ente locale è l’ICI,
appannaggio dei Comuni.
Una dilatazione di questa imposta a seguito della varata riforma del
sistema catastale, avrebbe come conseguenza quella di far pagare il
costo dello stesso ad una sola categoria economica: quella dei
proprietari immobiliari, in quanto possessori del bene-cespite (non già
percettori del reddito, dato il suo carattere di patrimonialità).
Aumentare quindi la capacità impositiva degli enti locali, ma realizzare
nel contempo un maggior equilibrio tra capacità fiscale locale e
prelievo locale attraverso due livelli di intervento.
A livello regionale, occorre dare attuazione e potenziare la
compartecipazione dell’ente regione alle imposte indirette erariali
(anche per riequilibrare il rapporto sbilanciato che esiste fra le
imposte statali).
Per quanto riguarda viceversa il livello comunale lo strumento della
compartecipazione non è adatto a risolvere il problema del concorso dei
city users nel finanziamento (in rapporto ai servizi goduti) del
bilancio del Comune nel cui territorio gli stessi esercitano l’attività
lavorativa.
E’ chiaro infatti che la compartecipazione funziona a favore del Comune
di residenza e non di quello in cui i cosiddetti pendolari producono il
reddito lavorativo; consumandovi, nel contempo cinque o sei giorni su
sette, i relativi servizi.
Occorre dunque (ma bisogna uscire dalla logica semplicistica della
dilatazione dell’ICI perchè, in questo caso, il federalismo si farebbe -
giova ripeterlo - a carico di una sola categoria di contribuenti)
istituire una imposta comunale. Imposta che abbia la più larga base
imponibile possibile, in termini di categorie e di contribuenti
assoggettati. E quindi si riferisca a tutti i redditi lavorativi,
prodotti nel territorio comunale, da residenti e da pendolari: imposta
detraibile da quelle erariali, ovviamente, onde realizzare al tempo
stesso il non aggravio del contribuente ed il trasferimento della
risorsa fiscale dallo Stato al Comune». (CS dell' Associazione)
|